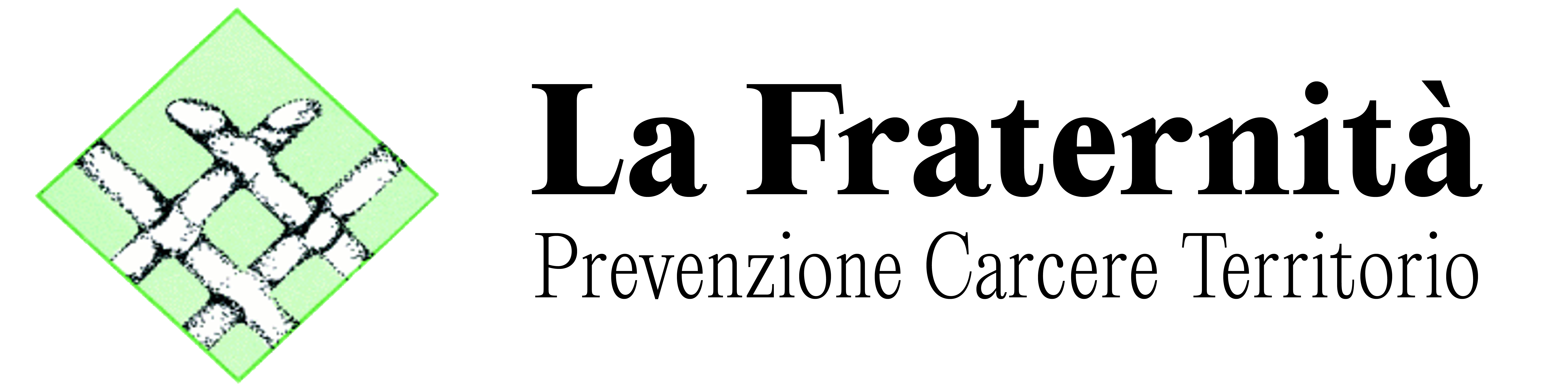Aula dell’università affollatissima il 5 dicembre u.s. per l’incontro su “Legalità e senso civico” nel ciclo “Essere italiani oggi – Per un’identità politica, culturale e religiosa”.
Dopo i complimenti di Donata Gottardi alla partecipazione degli studenti, Gherardo Colombo si chiede se sono quasi tutti fuori corso o se siamo all’università della terza età. Osservazione che gli ha consentito di rinunciare alle tecniche didattiche con cui di solito si rivolge ai più giovani e di esporre invece direttamente alcune riflessioni.
Che relazione c’è tra noi e le regole? Se la trasgressione è marginale, possono bastare gli apparati di controllo, ma se è generalizzata, frutto di una mentalità diffusa, allora non è con le sanzioni che si risale al cuore del problema. Le regole ci appaiono ostili perché le vediamo come comando o divieto, come interferenza nella nostra libertà. E in effetti nella storia le discriminazioni (non ultima quella di genere) si sono sempre esercitate attraverso le regole. Ma la nostra Costituzione ha operato un rovesciamento, riconoscendo la pari dignità di ogni persona ed introducendo regole che non rappresentano limiti ma possibilità: l’affermazione e la tutela di diritti, di libertà, al cui esercizio sono funzionali i comandi e i divieti.
A chi non vede il collegamento tra libertà e obbligo di pagare le tasse, Colombo racconta le vicende dell’evasore pentito che, per non ricorrere ai servizi ai quali non ha contribuito, deve privarsi di tutto, dalla luce alle strade, all’acqua, alle cure mediche, alla protezione di polizia, e capisce che tutto attorno a lui esiste proprio perché si pagano le tasse. Le regole sono una condizione di felicità.
Non basta però che le leggi siano scritte. Cos’è necessario ancora?
– che ci sia qualcuno che le faccia rispettare (togliendo quindi libertà), oppure
– che le rispettiamo.
L’art. 1 della Costituzione si può leggere nel senso che la Repubblica è democratica solo in quanto i cittadini si impegnano, col lavoro, la cultura, le relazioni, ecc., affinché lo sia. Ognuno di noi ha il compito (messaggio positivo, non “deve” che suona come imposizione) di osservare le regole per essere libero, lui quanto gli altri.
Se la conseguenza del mancato rispetto delle regole consiste nell’infliggere del male, che cioè il rimedio al male sia dell’altro male, non riconosciamo la pari dignità dell’altra persona. Come si può pensare di arrivare al bene attraverso il male?
La domanda apre una prospettiva a don Luigi Ciotti, nato nel cuore delle Dolomiti e quindi lui stesso “patrimonio dell’umanità”, prima di trasferirsi con la famiglia in una baracca di Torino e sperimentare la discriminazione. I due pilastri della democrazia, spiega, sono la giustizia e la dignità, ma la spina dorsale che le permette di reggersi è la responsabilità. Siamo chiamati a rispondere di quello che facciamo, e prima di tutto di quello che avviene dentro di noi. E’ già nella nostra testa la zona grigia di confine malleabile tra legalità e illegalità, adattato alla convenienza.
Veniamo da un coma etico, che si è propagato per imitazione, o per sfiducia, o per ribellione in mancanza di quel che sarebbe necessario: di adulti credibili, di empatia, di autenticità.
Come sempre negli interventi emotivamente tesissimi (ed appassionanti) di don Ciotti, le riflessioni fanno tutt’uno con il racconto di storie e momenti esemplari, come l’incontro di Papa Giovanni Paolo II con i genitori del giudice Livatino, assassinato dalla mafia, e il suo grido alla legalità, spontaneo e insistito, al quale poi si è ispirato il documento dei vescovi del 1991, definendola esigenza fondamentale per promuovere lo sviluppo della persona umana verso il bene comune.
Non sempre le leggi la rispettano, per esempio il reato di clandestinità è contro i diritti umani. Dobbiamo quindi impegnarci per cambiarle, con gli strumenti legali, o trasgredirle facendo obiezione di coscienza e accettando di pagare di persona le conseguenze.
Secondo stime della Banca d’Italia il riciclaggio, vero ponte tra la criminalità e la società civile, vale almeno il 10% del PIL, una cifra enorme. Ma è dal 1999 che l’Italia non traduce in norme penali quanto chiede la Comunità europea contro la corruzione, anzi va in senso contrario, come le leggi sul falso in bilancio e tante altre.
In un’etica della responsabilità, se giustizia è la sostanza, la legalità, cioè il rispetto anche formale delle regole è la saldatura tra la persona e la giustizia.
Don Ciotti racconta ancora di don Puglisi, assassinato perché prete contro la mafia (a differenza forse di altri prelati), della ragazza di Partanna, figlia di boss ma diventata convinta collaboratrice di giustizia e suicida dopo l’assassinio del giudice Borsellino; la tomba di questa ragazza, subito devastata, è ancora senza nome per il veto mafioso. Ma ad un convegno sportivo è stata accolta la proposta di far giocare la nazionale di calcio, allenata da Prandelli, su un campo ricavato da un terreno sequestrato alla mafia, sul quale da 9 anni il potere criminale impediva ai ragazzi di giocare.
Vedi anche L’Arena del 6-12-11: "Si è veramente liberi osservando le leggi".
Vedi anche Verona fedele del 18-12-11: "La legalità malleabile: un vizio tutto italiano"